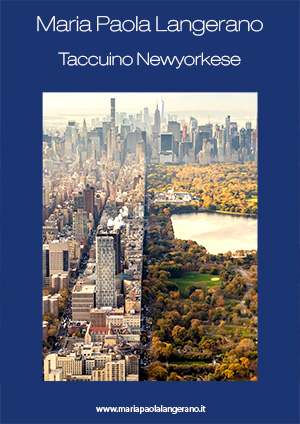Circolo-ciclico, iterazione-stupore – davvero siamo a New York? – sì, qui,noi tre a farci percorrere dai fili dell’alta tensione.
10 luglio, 00.58, venerdì. JFK Airport fino alle 2,40 per il controllo passaporti e visti di ingresso.
È il 10 da noi ma qui il giorno è ancora dietro la cortina della notte che sta per iniziare lattiginosa di nuvole e smog.
Un taxi e un indiano in turbante ci fanno strada in mezzo alla pioggia che scroscia improvvisa su Queens mentre noi cerchiamo qualcosa di familiare al di là delle immagini dei commercials trasmessi a ripetizione sul monitor del vetro che ci separa dal conducente.
Manhattan è lontana, oltre la pioggia e la nostra spossatezza di transoceanici.
Siamo a New York?
Manhattan si dichiara nella cuspide del Crisler Building, non me ne ricordo subito il nome, a mezzalune di luce, e in un’indicazione topogrfica: Park Avenue, ma è uno scorcio di strada stretta, con qualche albero, in cui una ragazza cammina veloce, in un abitino leggero, riparandosi sotto l’ombrello.
E poi luci a ripetizione e rumore e taxi gialli e automobili, automobili e Times Square.
Elettricità e pioggia.
Sono le 4, ci sistemiamo nella nostra stanza, la 1517, svuotiamo le valigie.
A letto, alle 4,30, è bello e morbido, coperti dal piumino, d’estate.
Ci svegliamo alle 5,25, ora locale, con il desiderio di spalancare le tende sulla città. Primo acquisto poco piu in là del nostro albergo, un riduttore a $ 29.90.
Colazione a Starbuck Coffee, dietro la 7th, dopo qualche indecisione, e Times Square, il bacio di Livia, la stupefazione, la ripresa televisiva, inciampati in uno sketch e pedinati per firmare l’autorizzazione alla messa in onda delle immagini.
Un boccone dietro l’altro per incominciare a catturare la città.
Prima degli altri Renzo Piano e la sua lettura del New York Times, con una boccata di verde al suo interno.
La Public Library, Bryant Park, un respiro felice.
New York, impossibile preda. Per il momento lieve capogiro e scollamento tra coscienza e percezione di essere qui.
A New York l’edificio non esiste nella sua individualità ma nell’insieme costruttivo dell’accostamento di piu fabbricati senza apparente respiro.
Sulla 5th cogliamo il primo istante di Empire State Building. La fila non è eccessiva. Interno Metropolis, pavimento e pareti virano bronzo/oro/argento.
All’ottantesimo piano si sale in 1’11”63”’.
Esterno, prima vertigine sulla città di cui ancora non riconosciamo il nome.
A Madison Avenue alla ricerca di qualcosa da mettere sotto ai denti. Abbuffata da Mc Donald e conseguente imbarazzo digestivo.
La Morgan Library, sulla Madison Avenue, è un altro Renzo Piano che ci andiamo a cogliere in mezzo alla Midtown.
Pagine di vetro, al colore dei sogni di noi che leggiamo.
È sempre il medesimo edificio quello che lui immagina e realizza con grazia, in punta di dita, disteso, appeso all’aria della città, ancorato ad un concetto di verde nel cuore, rinnovata concezione di peristilio, esile nel dettaglio di verde e di erba flessuosa, spettinata.
Il verde a New York sono alberi isolati – olmi, forse? – prati di edera, a Bryant Park e nelle aiuole, Central Park, dalla terrazza dell’Empire, il Sarah Delano Roosevelt che fa il filo a Little Italy.
Lexington Avenue, Park Avenue e Grand Central Terminal. Mr. Cary Grant alla biglietteria e chilometri di pellicola sotto il soffitto verde turchese.
Lexington Avenue verso il Seagram Building di Mies van der Rohe.
Bronzo travertino acqua travertino serpentno acqua vetro linea retta esterno interno, taglia, dettaglio, asciutto spigolo.
Scopriamo il “fiammifero” con i suoi 425,50 metri di altezza, il più elevato grattacielo del mondo occidentale.
Rockfeller Center. Storditi dal fuso orario.
Sole e sole sulla Promenade, intorno alla Plaza dell’abete di Natale e della pista di pattinaggio su ghiaccio, dell’assurdo Prometeus, falso d’oro, fuori parte, con la storia di chi ha sfidato il cielo appiccicata addosso.
Amo il Modernismo nel laterizio delle cortine che interrompono la teoria del vetro. È la New York che, ad ora, preferisco, elegante nella verticalità spezzata.
Riposo in albergo, resistiamo. Scopriamo il nostro market dopo aver speso $7,70 per due bottigliette d’acqua in un bar.
Cena e ibernazione da Gallagher, con tanto di cameriere romano, a base di filetto alla griglia, mashed potatos, french fries e fagiolini della mamma saltati in padella con l’aglio.
L’aria condizionata mette a repentaglio la salute di Mac e la resistenza di Livia alle prese con una milanese dalle dimensioni abnormi.
11 luglio. Central Park, da Columbus Circle, ed è sabato e subito ciclisti e jogging.
Fa caldo e la città che ho davanti agli occhi si gode gli spazi verde prato, verde lago e alberi, consuma un pasto sull’erba, si sdraia e si toglie i vestiti sotto il sole.
Caldo. Umido, faticoso sul cuoio della borsa che ho portato con me. Pesante sulla schiena che mi duole, mi rallenta e pesa sui miei passi.
E tutt’intorno è un sabato di newyorchesi a diporto, sui prati, in bicicletta, sui pattini, di corsa, sul West Side, quello dei Sanremo Apartments, quello dei Dakota incappucciati dai lavori di restauro; e John è solo il bianco e nero delle tessere di un mosaico, stonato sugli abiti e i capelli dei due che stanno lì e che cantano le sue canzoni.
E questo è un Central Park che non riconosciamo, a parte l’orizzonte dei Sanremo.
Su e giù per i tronchi e sui prati lo show degli scoiattoli.
I panini che abbiamo acquistato alla pharmacy sono un’iperbole proteica che ci satura ai primi morsi.
Il Museo di Storia Naturale ci appare un po’ dimesso nel complesso, come questo Central Park, ad eccezione della hall scenografica che si apre oltre lo scalone di accesso.
Deludente.
Fuori ci attende ancora parco e caldo e un lungo percorso che ci spinge sul West Side dove digrada a mano a mano l’altezza dei grattacieli e sulle panchine siedono neri delle chiese avventiste con i loro abiti anni ’50 e gli opuscoli sulla luce di Dio.
Ancora avanti fino ad Harlem e la città cambia nome.
Neri anziani davanti ai bar, sulle sedie di casa, e donne e bambini sui ballatoi, penzoloni come l’inerzia di queste ore di sole che qualche chilometro più in là dora la pelle sudata degli atleti del fine-settimana.
Ci sentiamo a disagio, tutto sembra non muoversi, non mutare da tanto tempo.
Ci infiliamo nella subway dove un gentilissimo signore ci indica come passare i tornelli con la card. It’s so different e lui lo sa perché ha viaggiato.
Siamo diretti a Macy’s, in Herald Square, che ci delude.
Ritorno in affanno, in mezzo al popolo del sabato pomeriggio, al traffico caotico in una città maleodorante che ti lavora ai fianchi.
Cena in camera con frutta, yogurt e cereali, panino ai cereali, birra freschissima e Coca Cola. A nanna alle 21.30 senza doccia, senza denti lavati. In attesa di domani.
12 luglio, domenica
Evviva Livia e i suoi anni verdi!
Al Lincoln Center l’aria attraversa l’architettura e i fotogrammi dei nostri film.
“Stregata dalla luna”, la piazza dilatata sulla strada dalla magia del grandangolare. E la fontana che si eleva nell’acuto mentre lui l’aspetta, innamorato già perdutamente.
È bello stare qui a passo di danza, noi tre, vento tra le note e le parole che vorrei scrivere qui, leggére.
Due ore al Century 21 a caccia di affari. Bottino: tre paia di occhiali da sole Cole Haan – lo scontrino ci informa che abbiamo risparmiato ben 234 dollari! – e un paio di pantaloni di Tommy Hilfiger per the great Mac.
Ritorno per la nona verso Hell Kitchen, sparuto e in dismissione.
La nona rigurgita di vita, di edifici bassi e rossi di laterizio, diagonali di scale antincendio, fagocitati dai grattacieli delle nuove generazioni.
Colori nella gente di tutto il mondo e nei suoi ristoranti etnici. Ci torneremo.
Imbocchiamo la Broadway. Niente regali, oggi, per Lilù.
Stasera ancora a Bryan Park, per una Fifth dorata di tramonto.
Al grill Park Restaurant non serve la prenotazione. Ci accomodiamo sulle poltroncine di vimini.
Il parco è illuminato e quieto. Siamo felici.
Festeggiamo la nostra bambina e ci scattiamo foto in continuazione.
Lo ricorderemo sempre. Cena a base di pollo alla griglia, piselli inglesi, bacon e patatine fritte per Mac; filetto di maiale, piselli inglesi, puré di patate dolci e ali di melanzana dorate per noi ragazze. Squisito!
Brindiamo con un gelato misto e noccioline caramellate per il nostro, torta al cioccolato con cuore fondente e caldo per la festeggiata e una deliziosa interpretazione di cheescake con gelato alla vaniglia, fiore di pasta sfoglia per me.
Soddisfatti ci facciamo immortalare alla luce calda del locale e delle sue candele dal cortesissimo cameriere di colore che si è preso cura di noi.
Ritorno sulla Fifth.
Il negozio Sketchers è in chiusura.
13 luglio, lunedì. Subway, R, fino a White hall station per il ferry per Liberty Statue ed Ellis Island.
È bello allontanarsi da Manhattan per via d’acqua, cuspide che fende l’Hudson river. Ma a noi manca la prospettiva del migrante, veniamo da terra, procediamo in senso inverso, e la statua è un gigantesco souvenir che rapiamo con scatti a ripetizione ed Ellis Island uno stanzone rimesso a nuovo, che ha perso il filo del racconto.
Poi Brooklyn, Court Street Station. Bellissimo il colpo d’occhio all’uscita, alle spalle la Court, di fronte la Camdan Plaza e il parco con il memoriale per le vittime della seconda guerra mondiale.
Papà al telefono che mi parla ed è così contento dell’esperienza di questo viaggio e parla con Angelo e con Livia e i bambini giocano sul prato di erba sintetica.
Washington Street, elegante nel suo rinnovato arredo urbano, affiancata da gallerie, boutique e agenzie immobiliari. Europea.
Promenade. I piloni del ponte, gli edifici bassi in cortina rosso fucina, il piccolo parco giochi con carousel, e poi un altro con fontana e spruzzi per i più piccini.
Prospettiva su Lower Manhattan, capannoni e campi al coperto per promesse dell’NBA, sole che scotta e arsura.
Poi, da Harry Street, Montague Street che ci piace da subito, come tutta Heights Brooklyn in piena evoluzione, con i suoi isolati di discrete case basse a schiera, con le aiuole ben curate, i suoi market con prodotti un po’ più veri.
Assaggiamo l’acqua al sapore di pesca e di more, toast inglesi, the alla pesca, mirtilli e ciliegie per la cena di stasera.
Di nuovo in subway, sulla R, direzione miraggi di Herald Square per scarpe Sketchers, Converse e borsa Longchamp.
14 luglio, martedì. Stamane leggeri, senza acquisti alla pharmacy, una colazione a base di frutta, bagels e milkshake.
Lungo la Fifth è tutta un’altra cosa.
New York è New York, grigia e piatta di vento. Pioviggina a tratti.
Trump Tower spoglia dei giardini pensili di copertina. Boutique di Valentino e Armani, su, verso il Central Park.
Tiffany sfavilla miraggi.
L’Apple Store ci prende a scendere e salire vetro nella capsula dell’ascensore, nel suo cuore di cubo.
Fuori il Plaza Hotel color New York e autunno e Central Park.
Percorriamo la Literary Walk, l’elegante Mall, arriviamo alla Bethesda Fountain e Livia è felice perché riconosce il set di “Come d’incanto”.
Il parco qui è come noi lo immaginiamo.
Al Metropolitan Museum mi stordisco delle storie dei ceramografi greci perché c’è Exechias e i suoi cavalli di contro al tempo. E i velocisti panatenaici di Nikias, e Lydos, e il Pittore di Amasis, di Berlino. Io sono bianca.
Epifania di Giotto.
Scena immersa nella Storia che alla Storia imprime il sigillo di attimo ed eterno.
Da cielo a terra, angeli e pecore, a gradoni, l’uno sull’altro, come quelli della montagna su cui due frati si inginocchiano, a metà strada tra umile e eccelso, gli occhi a Dio.
Dolente Corot.
Cinque ore e venti al Met.
Tre pretzel veloci e lungo il Museum Mile siamo al Guggenheim. Perplessi.
Ritorno per la Fifth nell’Upper East Side, assolutamente elegante.
Siamo stanchi.
15 luglio, mercoledì. Linea E fino a Jamaica station e Air train to Jfk, Federal Circle Station per la nostra car a Long Island, che ci porterà da Gatsby.
Un intero Police Department at our disposal per ricevere informazioni già presenti sulla nostra carta di prenotazione…
That’s Mari’s style!!!
1: individuare l’automobile che abbiamo noleggiato. Sembra facile!
Mac occhialemunito recita nome della casa automobilistica, tipologia e colore vettura, come da ricevuta di pagamento. Sarà la Mitsubishi bordeaux che ci occhieggia appena usciti dall’ufficio della Europe rent car? Non rientra nelle dimensioni indicate dal nostro, al momento della prenotazione da Roma.
Del resto, il provvidenziale intervento di Livia che spezza risolutamente gli indugi, impugnando il telecomando che sblocca le portiere, ci consente di entrare e di sistemarci comodamente all’interno dell’abitacolo.
L’evidenza non convince Mac che ci ingiunge di raccogliere immediatamente le nostre cose e di scendere, alla ricerca della vettura a noi assegnata.
2: avviare il motore. Con quale chiave? Mac, una volta risalito sulla Mitsubishi, sfiorato dal dubbio che non sia proprio quella l’auto che abbiamo noleggiato, non si arrende all’ipotesi che il mezzo sia automatico, ergo che non sia munito dell’abituale serratura in cui infilare la chiave. Anche perché non ci è stata consegnata alcuna chiave…
3: inserire la marcia – sì, vabbè – e partire.
Le vocali indicano le consuete operazioni che un guidatore effettua nell’espletamento delle sue funzioni. Sì, un guidatore anglofono! E data la naturale inclinazione di Mac per le lingue straniere…
4: trovare la 27, la strada che ci condurrà lungo Long Island, fino agli Hamptons. Peccato che non ci siamo ancora muniti di mappa, nonostante le mie ripetute raccomandazioni di fermarci alla più vicina gas station.
Consiglio sosta tecnica di fronte ad una scuola dove adocchio un distaccamento di Fireman che si sperticano nel tentativo di spiegarmi sinteticamente la viabilità extraurbana dell’isola.
E’ fatta, imbocchiamo la 27!
Viaggio piano, naturalmente piove.
Patchogue on the bay. Pranzo da Lombardi, sulla terrace in front of the bay: rigatoni con polpette e ricotta e insalata di polpo per Lilù; panino con lobster e french fries per noi. Si brinda con birra e Coca Cola.
Tenero grigio. Qui dove migrano stormi di anziani a prendersi l’aria della baia, piatta, aria di laguna, stesa sotto il cielo, incapace del vento del mare che si intuisce al di là del tombolo.
Patchogue on the bay dove sabato ci sarà il festival del jazz, no, noi non saremo qui, dico al cameriere biondo spento come la baia, noi stiamo a Manhattan.
Potremmo prendere un ferry che ci porti sull’oceano ma da qui è bello guardare oltre la linea del tombolo. A Patchogue dove tutto può succedere perché è compressa un’ansia rarefatta, nella lentezza delle cose che compongono il paesaggio, un’elettricità sottesa, che sfiora appena l’acqua della baia, che ci dice di andarcene via, presto, da questo posto, perché potrebbe non esserci più il tempo.
Verso gli Hamptons, sulla strada che attraversa l’isola che si allunga come dall’aereo, al nostro arrivo – stesso grigio – tra il canale naturale di Long Island Sound e l’oceano, fino a Southampton, dove non scendiamo nemmeno dall’auto perché temiamo di non arrivare entro le 20.30 a riconsegnarla. E dobbiamo tornare indietro, fermarci a Long Beach dove il mare è Oceano e le onde sono accese e pesanti.
A Long Beach corre lunga una passerella di legno, in front of the sea, e si passeggia, si corre, si va in bicicletta, ci si ferma sulle panchine a guardare il mare.
Il legno è morbido di sale, accoglie le orme dei nostri passi prima di scendere sulla spiaggia grigia e nera di surfisti in muta. Di ogni età, sorridenti a noi che passiamo e ci scattiamo foto mentre andiamo e Livia si bagna e compone una danza nelle immagini che ci restano di questo scorcio di mercoledì, una giornata che non ha il sole e è un po’ bagnata, quasi fuori stagione, ma si muove con il vento e con noi che ci andiamo addosso e siamo felici di essere qui.
Bisogna ripartire, è quasi il tramonto.
Il ritorno è avventuroso perché sulla strada che attraversa Long Beach non ci sono indicazioni per il JFK. Il casellante ci dà un’informazione sbagliata ma nel traffico della sera ci viene in soccorso un automobilista che ci riporta al terminal.
Siamo stanchi. Treno e Subway fino in albergo, dove ceniamo con le vettovaglie della pharmacy.
C’è un uomo a Patchogue on the bay che ha perso il nome. L’ha perso nella baia ed è difficile che lo ritrovi perché la baia fa i giorni tutti uguali e se si perde il senso non si ritrova più la direzione.
16 luglio, giovedì. Primo giorno di shopping, alla ricerca delle Converse per Livia, passando per Union Square, dove Mac ed io acquistiamo le Sketchers; il Village, Washington Square che sorride di gente che non va di corsa, si gode uno spettacolo di musica all’aperto, prende il sole sui ritagli di prato, legge il giornale sotto gli alberi. Studenti universitari in pausa.
Little Italy si è ridotta a poco più di una strada, ammiccante di ristoranti e pizzerie tricolori, una quinta di operetta di maniera, e noi non ci sottraiamo al nostro ruolo e ci mangiamo una pizza da Nico, accomodati ad un tavolino all’aperto, su Mulberry Street. E’ una giornata tersa che sembra settembre.
Chinatown è subito oltre Canal Street, prende il sopravvento con l’odore di pesce dei suoi banchi sui marciapiedi, i carrettini di frutta, i negozi di giada e ventagli, le scale che scendono in locali commerciali sporchi e maltenuti.
Vogliamo lasciarci alle spalle questa sensazione di sudicio.
C’è un piccolo parco. La gente forma crocchi intorno ad artisti di strada che cantano e danzano. Per terra cartacce e giornali cinesi.
All’uscita, in un’aiuola dietro una panchina, i ratti entrano ed escono dalle tane. I due cinesi sulla panchina sorridono del nostro raccapriccio.
Oggi è la tipica giornata del turista sfaccendato. Entriamo ed usciamo, come i ratti dell’aiuola, dagli stores sulla Broadway e manchiamo il Memorial dell’11/9 perché si è fatto troppo tardi tra Ray Ban, magliette di Calvin Klein, jeans, Converse di tutte le fogge e colori – noi cerchiamo quelle basse, con la bandiera americana – di cui non si riesce a trovare il numero.
Facciamo un salto al Financial District che è il tramonto. Wall Street sfavilla di dollari, luci e bandiere americane sullo stilobate rialzato del tempio della finanza mondiale, con tanto di bull che carica dietro l’angolo.
Una giornata all’insegna dello shopping non può che concludersi con un salto nel caotico Century 21 e poi via, in metro, verso il gelato e la frutta della pharmacy, sui triclini della nostra camera.
17 luglio, venerdì. Stamattina pancakes a colazione! Una porzione da oltre 600 calorie! Ci mettiamo alla ricerca della Rizzoli, al numero civico 31 della West 57th, all’angolo con la 5th. Avanti e indietro, attraversando la 5th, perché non ne troviamo traccia e non vogliamo credere che lo spazio vuoto tra due grattacieli, dietro la rete dei lavori in corso di un cantiere edile, segno evidente di una recentissima demolizione, stia a significare ciò che temiamo.
La Libreria Rizzoli, storico ritrovo degli artisti e degli intellettuali della Grande Mela, immortalata in pellicole immortali, non c’è più. Polverizzata insieme all’edificio che l’ospitava.
Qui nulla è per sempre, neanche un’icona come la Rizzoli può sottrarsi alla sorte della rottamazione. Del resto, procedndo sulla 5th, in direzione Central Park, scopriremo ben presto che la stessa Moira ha reciso anche il filo di Fao Schwarz, smantellato in tre giorni – ci eravamo passati davanti martedì e ci eravamo ripromessi di visitarlo oggi – e cancellato dall’immaginario collettivo di milioni di bimbi di tutto il mondo.
A New York la vita si declina al presente.
Ci riprendiamo da Tiffany dove ci accolgono due uomini in abito scuro che sfoderano il più soave dei sorrisi e ci ringraziano per aver scelto di entrare nella boutique.
Il piano terra è una cattedrale di bagliori e raccoglimento.
Il terzo, invece, pullula di voci e di clienti sorridenti e soddisfatti di aver trovato il gioiello fatto a misura delle proprie tasche. Un gioiello d’argento, off course.
Noi usciamo con un bottino di quattro cuori d’argento, e un tondo con la L di Livia, ciondoli ricordo per me – dono di Mac – e per le “tre donne che intorno al cor mi son venute”: la mamma, la Bambi, la mia Milla.
I nostri giorni newyorkesi sono ormai solo spiccioli e abbiamo ancora in programma più visite di quanto il tempo a disposizione ci possa consentire.
La prossima tappa è la teleferica sul Queensboro Bridge, su Roosvelt Island, alla ricerca della prospettiva di Woody su Manhattan.
Il ponte color bronzo, il più prezioso, in mezzo alla città che cresce senza sosta, il nostro “fiammifero”, 432 Park Avenue, che svetta sullo sfondo.
Livia costruisce per me e per Mac la locandina del nostro viaggio, in faccia all’Hudson River e a Manhattan.
Sosta da Angelo per una pizza e mirtilli e ciliegie bianche da un ambulante per rinnovare il gusto di Brooklyn.
Continuiamo a piedi fino al Palazzo di Vetro.
Anche oggi è caldo e qui lo sentiamo di più perché siamo nel dopopranzo, camminiamo da stamane, e c’è un’aria che non ci piace.
Il quartiere è degradato, è stato accantonato da una parte, lontano dalla propaganda, come la pace, a cui nessuno sembra voler dare una possibilità.
Una scommessa persa in partenza.
Il Palazzo delle Nazioni Unite è un’opera di perfetta eleganza, che si sfila dal tempo e assurge alla dimensione della classicità, nella composizione di materiali diversi che si armonizzano cedendosi reciprocamente il passo, lungo i fianchi, sulla facciata di piani di vetro che si marcano in un ritmo di acciaio, in un doppio meandro del ventesimo secolo.
Ritorno per una breve sosta tecnica in albergo e giù nella subway fino al World Trade Center, al Memorial 11/9.
“No day shall erase you from the memory of time”. Virgilio, IX libro, Eneide.
Qui dentro dove tutto è voragine e lamiere contorte, e radici sradicate, e nero-fumo di ustione, e grida, e polvere, e fossa comune.
Anche fuori il capogiro della vertigine dell’acqua nelle vasche delle due fontane, che scende negli abissi, sul luogo dove si ergevano le Twin Towers, incise dei tremila nomi di chi ci ha perso la vita.
Ma qui manca l’aria, siamo spinti sottoterra dalla mano della Storia, mandata in onda a ripetizione dai monitor che trasmettono le immagini dei notiziari televisivi dell’11 settembre, dalle registrazioni delle voci di chi sta per prendere commiato da tutto, anche da se stesso, dai volti sorridenti delle fotografie delle vittime.
E’ tutto scuro. Azzurro solo il colore dei fogli di carta. Azzurro Virgilio.
All’uscita Mr. President.
Cena dietro all’albergo, in un posto americano per turisti, a base di hamburger e patatine fritte e ultimi sopralluoghi per pensierini da riportare a casa.
Sabato viene giù una pioggia che raffica i marciapiedi. Ci infiliamo nella subway fino al’esile Flatiron, il Korov’ev-Fagotto del nostro romanzo newyorkese, che ci siamo dimenticati in mezzo ai mille giri e ritorni su noi stessi.
Sbagliamo direzione del treno e perdiamo un’ora e il tempo ormai ci stringe. Acquistiamo la statua della Libertà di Max e l’Empire, per la mia collezione. Ardite architetture di carta.
Subway sulla via del ritorno e negozio OMG per magliette e Levi’s.
È tempo di partire.
In taxi salutiamo all’indietro tutti i passi della nostra meraviglia.
Ciao, abbiamo lasciato sul sentiero briciole per non smarrire il ritorno.
New York, 10 luglio 2015 – Roma, 14 gennaio 2016