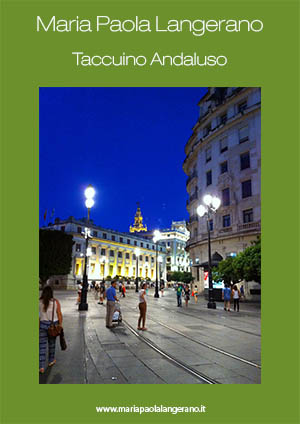L’Andalucia è stata il viaggio che ho continuato a percorrere per tutta l’estate che è seguita; Oriente giallo di pietra e verde di teoria di giardini e palme; Sultano e Imperatore; terra di sbarco dall’Africa, di là da Gibilterra, e fiume che porta all’Oceano per salpare, facendo rotta sul Plus Ultra.
Arrivo al vento, caldissimo, verso le 20.00 dopo un viaggio a temperature polari.
Il panorama, dalle isole Baleari, ci ha accompagnato nel cuore dell’Andalucia, adagio, con il mosaico dei campi coltivati, l’ocra di terra arsa, a livrea di serpente del deserto.
Le vipere si annidavano tra le zolle della terra lavorata con fatica, ricorda Levi, “Cristo si è fermato a Eboli”.
Taxi e arrivo all’hotel Zaida, in un abitato a tracciato arabo, di vicoli e case basse. È già tardi, il selciato rilascia il calore del giorno.
Il ragazzo che ci accoglie alla reception è simpatico. Ci scarabocchia – con nostro disappunto – la pianta di Sevilla con i nomi dei ristoranti che ci consiglia. Siamo affamati, non riusciamo a raggiungere i locali segnalati.
Il Patio di San Eloy ci entusiasma per il suo aspetto di bottega di mercato a degustazione di salumi e pescado, le azulejos blu e gialle, la vivacità degli avventori a cui senza indugio ci uniamo in un angolo – rincon – lurido, per la verità, ma che non ci scompone, non mi scompone, più di tanto per la fame feroce che ci attanaglia.
Insalata di polpo per tre, jamon iberico, tortilla de patata, pane e tarallini, cerveza Cruz Campo, Pepsi e una manciata di carcasse di gambero ai piedi di Livia!
Ora siamo pronti a scoprire la città che subito ci sembra bellissima, fascinosa sotto il drappeggio dei velari parasole, tra i tetti dei palazzi, la luce del giorno che indugia, il colore caldo della pietra degli edifici, le piante di agrumi, la gente nelle piazze.
Calle de la Constitucion, la Cattedrale, la Giralda, il palazzo reale, Placa San Francesco.
La mattina seguente il cielo è coperto e la temperatura vira decisamente al fresco – meno male – fino a mezzogiorno.
Colazione in un bel locale di fronte alla cattedrale, a base di caffè, zumo de naranja natural, bocadillos al jamon iberico e cannolone alla crema di cioccolato.
Sosta tecnica in farmacia per Mac che vuole emulare Russel con l’indice della mano sinistra (è stato punto da un’ape, il sabato precedente, mentre sconsideratamente sgarzolava con altri buontemponi del par suo, in scooter, senza parabrezza, nella Maremma… mah!).
Ivi prodezze linguistiche del nostro che abbozza una descrizione della patologia da cui è affetto, indicando il proprio dito, e, comunicando in un improbabile francese per identificare l’ape, conclude senz’altro con un’onomatopea sibilante, sottolineata dalla vivace mimica. Zzzzzzzzzzzz…
Messa in cattedrale, in una cappella laterale con una formidabile pala d’altare. Sento il bisogno della comunione anche se ho disertato qualche domenica e non mi sono confessata. Sono migliore dei miei accessi di nervosismo e insofferenza. Chiedo aiuto e perdono.
Non si riesce a cogliere l’interno della cattedrale in una visione d’insieme. Un coro ingombrante spezza e appesantisce lo spazio architettonico. Legno, marmo e ferro, nella cancellata; cesello senza soluzione di continuità a dispetto del materiale.
La cattedrale ha occupato lo spazio della moschea, ne ha cancellato la presenza.
All’esterno, in copertura, una prospettiva di archi rampanti e guglie, balaustre, vuoti e pieni, timbri acuti.
Un chitarrista attacca il “Concerto di Aranjuez”.
Non è possibile l’ingresso nel chiostro degli aranci, sottolineato da un arco la cui tipologia – un rettangolo, la porta, sormontato da una sfera – richiama alla memoria un’impressione di Aleppo, nella cittadella degli Omayadi.
Rubescente di falso antico, come le colonne del palazzo di Cnosso, la Porta dei Leoni che sembra trasportata qui dal set di un film di cappa e spada.
È un merletto lo spazio decorato nella misuratissima Sala della Giustizia, a pianta quadrata, con un soffitto ligneo a cassettoni dove si intersecano ottagoni e stelle, centrata su una piccola vasca lustrale, su un pavimento in cotto listato di azulejos.
Il Patio delle Fanciulle è il cuore del palazzo; sulla destra l’alcova e sulla sinistra la Sala del Trono di Carlo V.
Linea di fuga del corridoio d’acqua che l’attraversa, la Sala degli Ambasciatori, cui segue la Sala del Trono di Filippo II.
Corridoi cesellati di stucchi e di luce dorata e ovunque azulejos con i colori delle bandiere dei paesi arabi: ocra, verde, nero.
La sala degli Ambasciatori con la sua cupola di legno interlacciato di stile moresco.
L’Alcazar è nel suo esterno che dal Giardino dello Stagno diventa labirinto di bossi e bosco di palme e aiuole di agapanto, fiore d’amore.
Nel giardino inglese ci sediamo ad ascoltare gli uccelli.
Sfiliamo al cospetto del Sultano, un pavone che si allunga altero sull’erba.
Sono quasi le quattro, girovaghiamo intorno a Sierpes e ci fermiamo a pranzo a la Bodega dove Mac assaggia il baccalà e la Bambi ed io ci ingozziamo di cordon bleu, crocchette, patatine fritte e insalata russa.
Rientriamo in albergo, ci riposiamo e usciamo nel quartiere di Santa Cruz, un abitato interessante, da città di mare.
Si ha sempre l’impressione che dietro il vicolo appaia all’improvviso il mare. Anche i colori sono quelli di una città di mare. Ricorda Positano, dice Mac. È un’aria di mare caldo, un mare che alle spalle ha il deserto.
Sul selciato l’odore pungente e torrido, sulle lastre di basalto, sul pavimento tirato a lucido dai passi della gente. Percorriamo lo stradone Mendez y Pelayo che ci porta fuori dalla città e non ci piace.
Svoltiamo in una stradina sulla sinistra che ci conduce alla chiesa di San Esteban che ha proporzioni e facciata romaniche cui sono stati applicati due portali di ingresso gotici, e alla Casa di Pilatos da cui Mac attende di veder uscire Zorro…
Questa sera ceneremo a Los Coloniales ma c’è troppa gente e siamo costretti a passare oltre, alla volta del Dos de Mayo che, ahinoi, è chiuso.
Ripieghiamo su un lurido Patio di San Eloy, prossimo alla chiusura, che ci disgusta, e su tre insalate di tonno e pomodoro.
7.VII. Colazione vicino allo Zaida, da una deliziosa signorina che ci serve bocadillos, churros e donut al cioccolato.
Passeggiata lungo il Guadalquivir di palme e canoe, della Placa de Toros e della Torre del Oro, fino alle bizzarrie barocche di Palacio San Telmo.
Il Guadalquivir a regime del Canale di Alfonso XIII che lasciamo per inoltrarci nel Parco di Maria Luisa e raggiungere Placa de Espana e il suo anacronismo di azulejos, in pieno 1929, lo stesso anno del Padiglione di Barcellona di Mies van der Rohe.
Passiamo il fiume e passeggiamo tra i vicoli e le case dei pescatori di Triana. Insalata di pomodori in un baretto all’aperto.
Fa caldo, torniamo sull’altra sponda del fiume, all’Università, fino al monumento al Cid Campeador e, lungo i giardini del Murillo, rientriamo per via de la Agua a Santa Cruz.
Una granita di limone ci rinfranca.
Sosta in albergo e, verso le 19.30, di nuovo a zonzo, attraverso il quartiere di San Vicente, a Placa San Lorenzo dove i bambini giocano a pallone.
La Alameda de Hercules si rivela una delusione ma noi dobbiamo arrivare fino a qui, dato che domani giungeremo “ a quella foce stretta dov’Ercule segnò li suoi riguardi acciò che l’uom più oltre non si metta”.
Las golondrinas, il terzo ristorante suggeritoci dal nostro simpatico portiere, è chiuso! Ceneremo a Triana, in una friggitoria, in mezzo allo struscio serale sevillano.
Stasera,
al ritorno da Triana
sul Guadalquivir che corre all’Atlantico
il giorno stenta a cadere.
Il vento ai lampioni accende la luce.
La Giralda è lontana avanguardie di palme.
Noi lasciamo la città in questo istante
limpido.
8.VII. Lasciamo Siviglia ma è solo per qualche giorno. Il tassista che ci accompagna alla stazione di Santa Justa, a ritirare il nostro coche a noleggio, ci fa percorrere l’Avenida del Torneo, con tutte le sue storie di cavalieri e di duelli e di parate militari, la riva del Guadalquivir fino al ponte di Calatrava, il quartiere della Macarena, così detta perché vi si estendeva la proprietà di un certo Macarius, e lo splendido perimetro delle mura arabe in cui si aprono le porte monumentali le cui vestigia riappaiono nella toponomastica delle strade.
Il nostro tassista è un appassionato sevillano.
In viaggio – Sevilla – Las Cabezas de San Juan per Espera e Arcos de la Frontera che lambiamo, diretti a Vejer de la Frontera.
Vorrei ricordare, adesso che ne scrivo, esattamente, come in una ripresa a carrellata lunga, la terra di Andalucia, da Sevilla a Espera, verso Arcos de la Frontera.
Paesaggio a lievi ondulazioni e piane
rivestito di girasoli
di un tempo e di uno spazio lontano
di spostamenti lenti
tra gli insediamenti agricoli
di fattorie recintate da mura bianche
castrum di frontiera
devoti alla terra e alle campane della chiesa.
Scorcio intatto.
A Vejer de la Frontera, lungo una strada, a sinistra, si arriva a Capo Trafalgar.
Mac ancora una volta mi conduce al centro di ciò che voglio essere.
La punta, oltre la duna, e Atlantico piatto che non sa di battaglia. Oceano dietro la svolta di terra battuta.
Ci sbarazziamo in fretta di tutto ciò che ci tiene lontani dal mare. E subito è acqua forte e fresco che scioglie e perdura.
In questo giorno di nitore penso a Mac
addosso a un panorama
alla suggestione di un concetto
in viaggio
dalle pagine di un libro per ragazzi
al vento.
Il promontorio di Gibilterra emerge all’improvviso, in cima a una salita, arcigno elmato, in faccia all’avanguardia dalla terra dietro il mare, sotto scacco di falangi di centri commerciali lungo la superstrada che va veloce nella piana e volta le spalle alla morbida e verde ondulazione dei pini marittimi della riserva naturale, da Barbate a Tarifa.
Algeciras, San Roque e autostrada per Malaga e l’estate a ripetizione.
Verso l’interno riconquistiamo il panorama delle Sierras e il silenzio. Ci inoltriamo su per una stradina e raggiungiamo quattro case bianche con quadrati di giardino, raggruppate in una frazione che nel suo nome ricorda la miniera.
Un caballero attraversa la strada.
Arrivo a Granada in coche. Ci raccapezziamo con facilità nella toponomastica cittadina e raggiungiamo il Carlos V, il nostro hotel. La stanza è comoda e spaziosa e alla reception siamo accolti da una ragazza di Palermo che vive a Granada da tre anni. Prenotiamo la visita dell’Alahambra per l’indomani.
Siamo ingiusti con Sevilla, come gli amanti che tradiscono perché incantati da una nuova malia.
È sera e ancora è luce alta quando arriviamo a Granada, rossa di Alahambra, dorata e calda del passeggio lungo la Calle de los Reyes Catolicos, di Puerta Real, sotto i velari, elegante.
9.VII.
Bisogna visitare l’Alahambra quando è mattino presto
e il parco ancora è macchia scura e fredda e umida di notte,
contro il cielo che vira di zaffiro
e la pietra rossa di fortezza.
C’è già tanta gente ed è un peccato perché dall’ombra scivola l’acqua e il canto degli uccelli.
Palacio Nazarios, Alcazaba, Generalife e acqua ovunque, nelle fontane dei patii, nei bacili di marmo al centro degli ambienti, nei bacini che specchiano facciate, lungo i corrimano delle scalinate del parco.
Acqua che scorre e stagna di ninfee
e odora di zagare, di gelsomini e rose
acqua che stilla nei silenzi delle stanze
sotto le volte drappeggiate di stucchi
eccellenza di bianco su bianco e ombra.
Giardino di delizia del sultano
da respirare in un solo colpo d’occhio
da un divano a misura di paesaggio
da sfogliare pagina a pagina.
Favola verde scuro.
Francisco Tarrega, “Recuerdos de la Alahambra”, il commiato.
Scendiamo lungo le mura, sull’acciottolato che attarda i passi, tra la collina della Alahambra e l’Albaycin, fianco a fianco con il Dauro.
Siamo stanchi, fa caldo; ripariamo su gazpacho e tortilla de patata a Navas, a La Ciquota.
Cattedrale di Granada.
Trionfo di oro e bianco cattolico di Reconquista, sigillo della Regina e del Re, della Chiesa unica e santa sullo Stato nazionale. Maestosa e inoppugnabile.
Nella sacrestia una statuetta del 1656 di Alonso Cano, verde petrolio e verde chiaro la veste e il manto. Vergine spettinata.
Lontano il silenzio di acqua e ombra dell’Alahambra.
Ci spingiamo nel quartiere dell’Università, assai degradato, fino alla chiesa di San Jeronimo, mai consacrata, in cui non riusciamo ad entrare. Fa parte del complesso del Collegio di San Jeronimo.
Torniamo sui nostri passi e giungiamo alla vivacissima Placa de Bib Rambla dove ceneremo con una pizza.
Un grande bazar.
Cappella Reale.
Isabella e Ferdinando sotto gli archi a luce larga, a sesto ribassato; oranti al cospetto dell’abside; in ginocchio, diametralmente simili nella somatica del volto, in fronte a una pala d’altare che sublima e atterra, sacra e potente; nel tripudio del candore del marmo; composti nella cripta in due casse scabre, accanto a Giovanna la Pazza e Filippo d’Asburgo, il Bello.
Lasciamo i confini del Regno su per l’Albaycin dei vicoli e delle piazzette, delle case bianco-calce, a patio, continuum di azulejos e alberi di agrumi, l’Alahambra in prospettiva.
Da Zyn musica dal canale della filodiffusione; acquistiamo i disegni a matita e la melagrana per Elisa.
Fa caldo e Granada ha il sole in faccia.
Un gelato, bocadillos preparati in albergo e Sierra Nevada per il pomeriggio.
I tornanti – e la città appartiene già ad un altro giorno – gli abeti che ritagliano il pendio fino a 2000 metri, la Veleta, in alto, che scambio per il Mulhacen perché svetta sul crinale.
Fuori scala sul paesaggio un centro sportivo e il motore di automobili tedesche in velocità.
Ci incamminiamo sulla strada d’asfalto, non siamo attrezzati.
Riempiamoci gli occhi
di quest’aria fresca di verde
di valle che scorre d’acqua.
Ricordo mio padre
ruscello e prato
io mio malgrado
a lui così uguale
un’ora lontana
a cucinare sui sassi
sotto la pioggia
il sole.
Un capriolo e la sua mamma. Mac, Livia ed io, tutti e tre insieme e vicinissimi, toccati dall’amore.
Due caffè, un Powerade, uno spot pubblicitario improvvisato dalla Bambi, in un baracchino.
Ritorniamo a valle.
L’aria riflette e moltiplica le Sierras.
11.VII. In viaggio.
Nel bookshop dell’Alahambra, mercoledì, all’uscita, mi ha colpita la fotografia di copertina dell’epistolario di Federico Garcia Lorca e Salvador Dalì, “Querido Salvador, querido Lorquito”.
Due ragazzi in pantaloni d’estate, freschi d’abbraccio, in riva al mare.
E mi rendo conto di non ricordarmi dove il mio poeta è nato, non l’ho portato con me in questo viaggio andaluso.
Fuente Vaqueros è sulla strada tra Granada e Cordoba.
Fa caldo, siamo partiti tardi, c’è un’interruzione proprio all’altezza della deviazione per Fuente Vaqueros. Ieri abbiamo pensato di passarci ma io, al solito, non voglio disturbare.
Livia mi condurrà per mano davanti a quella casa, è già deciso.
Andiamo da Federico
il sole batte
e si adegua il mio cuore.
Ci vengono incontro i pioppi e la terra grassa di bonifica e campi di tabacco. Essiccatoi abbandonati.
È una strada di povere case
quella dove è nato
di estremo confine
di secolo andato
di gente contadina senza vezzo
primitiva e ferina
di Meridione ineluttabile.
Lo stesso che da piccola mi metteva a disagio perché sordido e povero.
In questa casa è nato Federico, il 5 giugno 1898.
Fa caldo sotto il sole
ma Livia è accanto a me
sul marciapiede
e scatta foto
e lambisce con lo sguardo
l’emozione che io vivo.
Tende su di me
dita di seta e neve
a incantare l’istante
a custodirlo intatto.
Non voglio entrare in casa
è tutto morto.
Federico è del paesaggio
della vita minuscola del cosmo.
Migliaia di pioppi da Fuente Vaqueros e Valderrubio, a Calle Iglesia, dove la sua famiglia si trasferì quando aveva sei anni.
Corriamo verso Cordoba.
Si legge al primo colpo d’occhio
Cordoba
gialla di arenaria
e di Guadalquivir a briglia sciolta
ronda di cinta araba
chiaroscura di Mezquita.
Cordoba
di più di mille anni
mille archi
mille dardi di luce
mille gorghi.
Cordoba
che avviluppa e si allontana
tra le palme in fuga sulle Avenidas.
Saremo a Sevilla di qui a poco, a sera.
È bello ritornare con tutti gli scorci al loro posto, con i nomi a memoria di monumenti e strade, l’ultimo giorno da spendere ancora qui, a zonzo, a fare acquisti, a festeggiare Livia che compie dodici anni.
Ci accoglie il nostro simpatico portiere allo Zaida, in Calle San Roque, che ci sembra più bello di come l’avevamo lasciato, senza dubbio più pulito e accogliente, forse perché per questa notte la nostra stanza è comoda e ampia e dà sul ballatoio, al primo piano, colorato di azulejos.
Riusciremo a cenare da Los Coloniales, arriveremo per tempo.
Rientriamo in albergo piuttosto presto, siamo un po’ stanchi, la notte è calda.
Camera per quattro, blatta inclusa…
12.VII. E’ il compleanno di Livia. Lunga vita, amore mio!
I festeggiamenti hanno inizio con ricca colazione a base di ciambella di pasta sfoglia, alla Campana, all’aperto, seduti a un tavolino. E poi Sierpes e i suoi velari, Avenida de la Constitucion, Hospital de la Caridad, Alcazar, Santa Cruz, Hospital de los Venerables, las Terras, Santa Maria la Blanca e pranzettino a l’Alianza, a Joaquin Romero Murube; tortillas de patata.
Sono sempre io che temo di non riuscire ad afferrare, a raccogliere il dettaglio, a ricordare, che ho bisogno di conoscere il nome di tutto ciò che ho visto per non sovrapporlo a qualcos’altro, per conservarlo a lungo e farlo nuovo ogni volta che mi trovo a raccontarlo.
E’ il 12 luglio, oggi, e vorrei che Livia avesse tutto ciò che più le piace. Entriamo in ogni negozietto di Sierpes e Tetuan ma torniamo al Corte Inglès, per trovare una felpa blu, il mio unico regalo per il suo compleanno.
Al bar Zafiro, in piazzetta, ultima sosta prima di partire.
Andalucia.
Porta la luce dentro il nome.
E lontananze.
Plus ultra, come mi sono sentita io durante il viaggio, oltre il punto di fuga, oltre il più estremo dei suoi mari, a lambire, quasi, il Marocco – il mio corpo nelle acque calme della battaglia – nell’aria che ad ogni vicolo apre Sevilla al Nuovo Mondo.
Andalucia che mi è rimasta addosso per tutta l’estate che è seguita, ripetuta a memoria, riletta e ancora ritrovata nei versi di Federico, una volta a casa, nell’infanzia di pioppi e incanti, nella mia prima voce, alla scuola elementare, quando tra le mani mi tremò l’elegia del Chopo muerto.
Andalucia, 5-12 luglio 2014